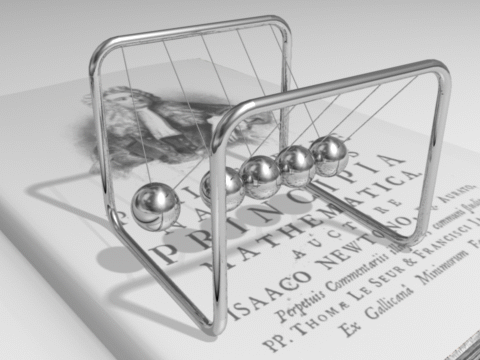Fra Seicento e Settecento il problema del tempo viene trattato in relazione ai dibattiti filosofici fondamentali che caratterizzano questi due secoli: in primo luogo, la questione metafisica della sostanza, e più specificamente del rapporto fra res cogitans e res extensa, fra spirito e materia, posta e lasciata pressoché irrisolta da Cartesio; poi, la disputa gnoseologica fra innatismo ed empirismo, che troverà nel confronto a distanza fra Leibniz e Locke il suo momento culminante e nella Critica della ragion pura kantiana una sintesi matura; infine, più in generale, le discussioni originate dallo sviluppo della scienza moderna, che pone alla filosofia l’esigenza di fornire a questa stessa scienza un’immagine del mondo caratterizzata da un ordine rigoroso e da punti di riferimento stabili, entro i quali poter determinare le leggi necessarie della natura. In relazione a queste tematiche generali, viene così posta anche una serie di questioni più specifiche, direttamente o indirettamente riguardanti la natura e la struttura del tempo. Il tempo è una sostanza o, almeno, un attributo fondamentale della sostanza, oppure è soltanto un nostro modo soggettivo di percepire gli oggetti, o, al massimo, un genere di relazione fra gli oggetti stessi? E’ il corso degli eventi, siano essi fisici o spirituali, è rigidamente necessitato; al punto che si potrebbe dire che il presente era già tutto implicito nel passato e il futuro lo è nel presente, oppure esiste nella realtà uno spazio di libertà e, quindi, di indeterminazione e di imprevedibilità?
Testo 17 – Spinoza: la visione della realtà sub specie aeternitatis
Come indica chiaramente lo stesso titolo dell’opera, l’Etica di Spinoza si propone di indicare al lettore un modello di vita: tale modello fondato sul perfetto adeguamento alla necessità che governa il tutto, potrà condurre l’uomo alla felicità. Tuttavia, per giungere alle conclusioni etiche che costituiscono lo scopo ultimo del suo lavoro, Spinoza ritiene di dover compiere un lungo percorso, che parte dalla metafisica e passa attraverso la gnoseologia. Nel suo aspetto formale l’opera riproduce esplicitamente l’andamento dei trattati di geometria. Va subito chiarito, peraltro, che, nell’intenzione di Spinoza, tale struttura non è un’imitazione estrinseca del modello matematico che nel Seicento riscuoteva largo consenso, bensì la forma che meglio si adatta all’oggetto dell’indagine: dalle definizioni poste alla base del ragionamento spinoziano deriveranno teoremi e corollari per la stessa rigorosa necessità con la quale dall’unica sostanza divina, che è il vero protagonista dell’intera opera, derivano tutte le sue manifestazioni. Questo stesso processo assume per Spinoza l’aspetto di una deduzione geometrica dei singoli enti dalla sostanza e quindi, se correttamente inteso, deve essere concepito come essenzialmente atemporale.
Definizioni
- Per causa di sé intendo ciò la cui essenza implica l’esistenza, ossia ciò la cui natura non può essere concepita se non come esistente.
Il. Si dice finita nel suo genere quella cosa che può essere limitata da un’altra cosa della stessa natura. Per esempio un corpo si dice finito, perché ne concepiamo un altro sempre maggiore. Parimenti, un pensiero è limitato da un altro pensiero. Al contrario un corpo non è limitato da un pensiero, né un pensiero da un corpo.
III. Per sostanza intendo ciò che è in sé ed è concepito per sé: ovvero ciò, il cui concetto non ha bisogno del concetto di un’altra cosa, dal quale debba essere formato.
- Per attributo intendo ciò che l’intelletto percepisce di una sostanza come costituente la sua essenza.
- Per modo intendo le affezioni di una sostanza, ossia ciò che è in altro, per mezzo del quale anche è concepito.
- Per Dio intendo l’ente assolutamente infinito, ossia la sostanza che consta di infiniti attributi, ciascuno dei quali esprime un’eterna ed infinita essenza.
Spiegazione
Dico infinito assolutamente e non nel suo genere; infatti, di qualunque cosa che è infinita soltanto nel suo genere possiamo negare infiniti attribuiti [cioè, si possono concepire infiniti attributi che non appartengono alla sua natura]; al contrario, alla essenza di ciò che è assolutamente infinito appartiene qualunque cosa esprime essenza e non implica alcuna negazione.
VII. Si dice libera quella cosa che esiste in virtù della sola necessità della sua natura e che è determinata ad agire soltanto da se stessa. Si dice, invece, necessaria, o piuttosto coatta, quella cosa che è determinata da altro a esistere e a operare secondo una certa e determinata ragione.
VIII. Per eternità intendo la stessa esistenza in quanto la si concepisce seguire necessariamente dalla sola definizione della cosa eterna[1].
Spiegazione
Infatti, tale esistenza viene concepita quale eterna verità, come l’essenza della cosa, e pertanto non si può spiegare mediante la durata o il tempo, anche nel caso che la durata sia concepita mancante del principio e della fine[2]. [ … ]
Proposizione XLIV
È proprio della natura della Ragione contemplare le cose non come contingenti, ma come necessarie.
Dimostrazione
È proprio della natura della Ragione percepire le cose veramente, cioè come sono in sé, ossia non come contingenti, ma come necessarie. C.V.D.
Corollario I
Ne segue che dipende soltanto dall’immaginazione che noi contempliamo come contingenti le cose sia rispetto al passato sia rispetto al futuro.
Corollario II
È proprio della natura della Ragione percepire le cose sotto una certa specie di eternità.
Dimostrazione
È proprio, infatti, della natura della Ragione contemplare le cose come necessarie e non come contingenti. Percepisce, inoltre, questa necessità in modo vero, cioè come è in sé. Ma questa necessità delle cose è la stessa necessità dell’eterna natura di Dio; è proprio dunque della natura della Ragione contemplare le cose sotto questa specie di eternità. Aggiungi che i fondamenti della Ragione sono nozioni che spiegano quelle cose che sono comuni a tutti e che non spiegano l’essenza di nessuna cosa singolare e che, perciò, devono essere concepite senza alcuna relazione al tempo, ma sotto una certa specie di eternità. C.V.D.[3]
Proposizione XLV
Ciascuna idea di qualunque corpo o cosa singolare esistente in atto, implica necessariamente l’essenza eterna e infinita di Dio.
Dimostrazione
L’idea di una cosa singolare esistente in atto implica necessariamente tanto l’essenza, quanto l’esistenza della cosa stessa: ma le cose singolari non possono essere concepite senza Dio; ma poiché hanno come causa Dio in quanto è considerato sotto l’attributo di cui le cose stesse sono modi, le loro idee devono necessariamente implicare il concetto del loro attributo, cioè l’eterna e infinita essenza di Dio. C.V.D.
Scolio
Per esistenza qui non intendo la durata, cioè l’esistenza in quanto la si concepisce in modo astratto e come una certa specie di quantità. Parlo, dico, della stessa natura dell’esistenza che si attribuisce alle cose singolari per la ragione che dall’eterna necessità della natura di Dio seguono infinite cose in infiniti modi. Parlo, dico, della stessa esistenza delle cose singolari in quanto sono in Dio. Infatti, sebbene ciascuna sia determinata da un’altra cosa singolare ad esistere in un certo modo, la forza tuttavia con la quale ciascuna persevera nell’esistere segue dall’eterna necessità della natura di Dio. [ … ]
Scolio
Le cose sono concepite da noi come attuali in due modi, o in quanto concepiamo che esse esistono in relazione a un certo tempo e luogo, o in quanto sono contenute in Dio e seguono dalla necessità della divina natura. Quelle che, dall’altra parte, sono concepite come varie ossia reali in questo secondo modo, noi le concepiamo sotto una specie di eternità e le loro idee implicano l’essenza eterna e infinita di Dio[4]. [ … ][5]
- Spinoza, Etica, trad. it. di F. Giancotti, Editori Riuniti, Roma 1988, pp. 87-88, 159-161, 309
Testo 18 – Newton: tempo assoluto e tempo relativo
Nella seconda metà del Seicento Newton propone una concezione dello spazio e del tempo come realtà assolute. Tale concezione è perfettamente funzionale alla fisica matematizzata quale si è venuta sviluppando a partire soprattutto dall’opera di Galileo. Uno spazio e un tempo assoluti sono, infatti, i punti fermi di riferimento entro i quali si possono individuare le leggi di funzionamento della realtà materiale espresse in termini matematici. Si pensi, ad esempio, alla legge di caduta dei gravi, nella quale si definisce un preciso rapporto numerico fra la velocità di un corpo e il tempo trascorso dall’inizio del suo movimento, cioè, in definitiva, un rapporto fra spazio e tempo. La convinzione di Newton, secondo cui una rigorosa fisica matematizzata si può costruire soltanto nell’ambito di una concezione dello spazio e del tempo come entità assolute, sarà condivisa un secolo dopo anche da Kant.
Scolio
Fin qui è stato indicato in quale senso siano da intendere, nel seguito, parole non comunemente note. Non definisco, invece, tempo, spazio, luogo e moto, in quanto notissimi a tutti. Va notato tuttavia, come comunemente non si concepiscano queste quantità che in relazione a cose sensibili. Di qui nascono i vari pregiudizi, per eliminare i quali conviene distinguere le medesime quantità in assolute e relative, vere e apparenti, matematiche e volgari.
Il tempo, vero, matematico, in sé e per sua natura senza relazione ad alcunché di esterno, scorre uniformemente, e con altro nome è chiamato durata; quello relativo, apparente e volgare, è una misura (esatta o inesatta) sensibile ed esterna della durata per mezzo del moto, che comunemente viene impiegata al posto del vero tempo: tali sono l’ora, il giorno, il mese, l’anno[6]. [ … ]
Comunemente in astronomia si distingue il tempo assoluto dal relativo per mezzo dell’equazione del tempo. Infatti i giorni naturali, che di consueto sono ritenuti uguali, e sono usati come misura del tempo, sono ineguali. Gli astronomi correggono questa ineguaglianza affinché, con un tempo più vero, possano misurare i moti celesti. È possibile che non vi sia movimento talmente uniforme per mezzo del quale si possa misurare accuratamente il tempo. Tutti i movimenti possono essere accelerati e ritardati, ma il flusso del tempo assoluto non può essere mutato. Identica è la durata o la persistenza delle cose, sia che i moti vengano accelerati, sia che vengano ritardati, sia che vengano annullati; per cui, e a buon diritto, questa durata viene distinta dalle sue misure sensibili; il che viene fatto mediante l’equazione astronomica[7]. [8]
- Newton, Principi matematici della filosofia naturale, trad. it. di A. Pala, UTET, Torino 1965, pp. 101-102, 105-106
Testo 19 – Leibniz: il tempo come ordine e relazione
Leibniz rimase coinvolto in una celebre disputa con Newton circa la priorità nella scoperta del calcolo infinitesimale. Dal punto di vista filosofico, tuttavia, è più interessante la polemica epistolare che lo contrappose negli ultimi anni di vita al newtoniano Clarke. Nelle lettere che i due pensatori si scambiarono, un tema centrale è quello della natura dello spazio e del tempo: mentre Clarke sosteneva, difendendo la posizione di Newton, il loro carattere assoluto, Leibniz proponeva una concezione del tempo e dello spazio come ordine e relazione fra gli oggetti. Malgrado la netta contrapposizione alle tesi newtoniane, resta comunque ferma anche in Leibniz la strettissima analogia fra le due dimensioni.
Mi si accorda l’importante principio che «niente avviene se non vi è una ragione sufficiente perché avvenga così e non altrimenti». Ma me lo si accorda in parola e me lo si respinge nel fatto; il che mostra che non se n’è ben intesa la forza. E perciò si adopera un argomento che cade proprio sotto una delle mie dimostrazioni contro lo spazio reale assoluto, idolo di alcuni Inglesi moderni. Dico “idolo”, non in un significato teologico, ma filosofico; come un tempo il cancelliere Bacone diceva che vi sono idola tribus, idola specus[9].
Quei signori sostengono, dunque, che lo spazio sia un essere reale assoluto; ma ciò li mette in grandi difficoltà. Infatti, pare che un tal essere debba essere eterno ed infinito. Perciò v’ha di quelli che hanno creduto che sia Dio stesso o il suo attributo, la sua immensità. Ma, siccome consta di parti, non è una cosa che possa convenire a Dio.
Per me, ho notato più di una volta che io consideravo lo spazio come qualcosa di puramente relativo, non altrimenti che il tempo; come un ordine delle coesistenze, allo stesso modo che il tempo è l’ordine delle successioni. Infatti, lo spazio segna, in termini di possibilità, l’ordine di quelle cose che esistono nello stesso tempo, in quanto esse esistono insieme, senza entrare nei loro modi di esistere particolari. E quando si veggono più cose insieme, si coglie tale ordine delle cose tra loro[10].
Per criticare la fantasticheria di coloro che prendono lo spazio per una sostanza, o almeno per un essere assoluto, ho parecchi argomenti ma ora voglio servirmi solo di quello di cui mi si fornisce qui l’occasione[11]. Io dico dunque che, se lo spazio fosse un essere assoluto, dovrebbe verificarsi qualcosa di cui non potrebbe esservi una ragione sufficiente: ciò che va contro il nostro assioma. Ecco in che modo io dimostro la cosa. Lo spazio è alcunché di assolutamente uniforme; e, senza le cose che vi si trovano, un punto dello spazio non differisce assolutamente in niente da un altro punto dello spazio; di qui segue (supposto che lo spazio sia in se stesso qualcosa, oltre l’ordine dei corpi tra loro), che non può esservi una ragione perché Dio, conservando le stesse posizioni dei corpi tra loro, abbia situato i corpi nello spazio così e non altrimenti, e perché tutto non sia stato invece preso a rovescio, (per esempio), con uno scambio dell’oriente con l’occidente. Ma se lo spazio non è altro che quell’ordine o rapporto, e non è proprio niente senza i corpi, tranne che la possibilità che ve ne siano posti; quei due stati, l’uno qual è, l’altro supposto a rovescio, non differiscono punto tra loro. La loro differenza, dunque, non interviene che nella nostra supposizione chimerica della realtà dello spazio in se stesso. Ma, nel fatto, l’uno e l’altro sarebbero precisamente la stessa cosa; e quindi non v’è motivo di chiedere il perché della preferenza dell’uno o dell’altro[12].
Lo stesso per il tempo. Supposto che qualcuno domandi perché Dio non ha creato ogni cosa un anno più presto, e che quella persona voglia inferirne che Dio ha fatto qualcosa senza che possa esservi una ragione per cui l’abbia fatta così e non altrimenti, gli si potrebbe rispondere che la sua illazione sarebbe vera se il tempo fosse qualcosa fuori delle cose temporali: infatti non vi potrebbe essere alcuna ragione perché le cose fossero attribuite a tali momenti piuttosto che ad altri, la loro successione restando la stessa. Ma proprio ciò dimostra che gli istanti, fuori delle cose, non sono niente, e che essi non consistono in altro che nel loro ordine successivo; e, questo restando immutato, l’uno dei due stati, per esempio quello della supposta anticipazione, non differirebbe in niente, e non potrebbe essere distinto, dall’altro che ora esiste[13].
Da quel che ho detto si vede che il mio assioma non è stato ben inteso, e che, con la parvenza di concederlo, me lo si respinge. È vero, si dice, che niente esiste senza che vi sia una ragione sufficiente perché esista, e perché esista così e non altrimenti; ma si aggiunge che questa ragione sufficiente è spesso la semplice volontà di Dio; come quando si chiede per che ragione la materia non è stata disposta diversamente nello spazio, conservando le stesse posizioni relative dei corpi. È proprio sostenere che Dio voglia qualcosa senza che vi sia alcuna ragion sufficiente della sua volontà, contro l’assioma o la regola fondamentale di tutto ciò che accade; ed è ricadere nell’indifferenza vaga, che ho ampiamente confutata, e mostrata assolutamente chimerica anche per le creature, e contraria alla saggezza di Dio, quasi ch’egli potesse operare senza ragioni[14]. […]
Non si può dire che la durata sia eterna; ma si può dire che le cose le quali durano sempre sono eterne. Tutto ciò che esiste del tempo e della durata, essendo successivo, perisce continuamente: e come potrebbe esistere in eterno una cosa che, per parlare esattamente, non esiste mai? Infatti, come potrebbe esistere una cosa di cui non esiste mai alcuna parte? Del tempo non esistono altro che gli istanti, e l’istante stesso non è parte del tempo. Chiunque consideri queste osservazioni, ben comprenderà che il tempo non può essere che una cosa ideale; e l’analogia del tempo e dello spazio farà giudicare che l’uno è tanto ideale quanto l’altro. Tuttavia, se, col dire che la durata di una cosa è eterna, s’intende dire soltanto che la cosa dura eternamente non ho niente da opporre[15]. […]
Io sostengo che, senza le creature, l’immensità e l’eternità di Dio non cesserebbe di sussistere, ma senza dipendere in alcun modo né dai tempi, né dai luoghi. Se non vi fossero creature, non vi sarebbero né tempi né luoghi, e, quindi, nessuno spazio attuale. L’immensità di Dio è indipendente dallo spazio, come l’eternità di Dio è indipendente dal tempo. Esse implicano soltanto, riguardo a codesti due ordini di cose, che Dio sarebbe presente e coesistente a tutto ciò che comunque esistesse. Non ammetto, quindi, quel che qui si asserisce: che, se Dio soltanto esistesse, vi sarebbero tempo e spazio, come ora. In quel caso invece, secondo me, essi non esisterebbero che in idea, come pure possibilità. L’immensità e l’eternità di Dio sono qualcosa di più eminente della durata e dell’estensione delle creature, non solo in rapporto alla grandezza, ma anche alla natura della cosa. Questi attributi divini non hanno bisogno di cose fuori di Dio, come sono i luoghi e i tempi attuali. Tali verità sono state sufficientemente riconosciute dai teologi e dai filosofi[16].
G.W. Leibniz, Epistolario Leibniz-Clarke, in Saggi filosofici e lettere,
trad. it. di V. Mathieu, Laterza, Bari 1963, pp. 400-402, 445, 461
Testo 20 – Kant: il tempo come forma della sensibilità
La Critica della ragion pura di Kant rappresenta un grande tentativo di sintesi conclusiva della disputa gnoseologica fra innatismo ed empirismo che aveva attraversato Seicento e Settecento, ma che affondava le sue radici già nella remota contrapposizione fra la teoria platonica della reminiscenza e quella aristotelica dell’intelletto come tabula rasa. La soluzione proposta nell’opera si presenta come intermedia fra le due alternative tradizionali e consiste, fondamentalmente, nell’ammettere la natura a priori delle forme della conoscenza e, contemporaneamente l’origine empirica dei suoi contenuti, che ne costituiscono, secondo la terminologia kantiana, la materia. Più in particolare, le forme della conoscenza sensibile vengono riconosciute nello spazio e nel tempo. Di questi, Kant accetta il carattere assoluto rispetto agli oggetti che era stato loro attribuito da Newton, respingendo quindi l’interpretazione, avanzata da Leibniz, che li intendeva come una relazione fra tali oggetti, cioè come l’ordine della loro coesistenza o successione. Ma Newton, per quanto riguarda specificamente il tempo, aveva distinto quello assoluto, che è tale non solo rispetto agli oggetti ma anche rispetto ai soggetti che lo percepiscono, da quello relativo, che misuriamo utilizzando come unità di riferimento determinati movimenti approssimativamente regolari, come quelli della Terra attorno al proprio asse o attorno al sole. Per Kant, al contrario, il tempo, così come lo spazio, è soltanto una forma della nostra conoscenza e non appartiene alle cose come sono in se stesse.
Esposizione metafisica del concetto del tempo[17]
- Il tempo non è concetto empirico, ricavato da una esperienza: poiché la simultaneità o la successione non cadrebbe neppure nella percezione, se non vi fosse a priori a fondamento la rappresentazione del tempo. Solo se presupponiamo il tempo, è possibile rappresentarsi che qualcosa sia nello stesso tempo (simultaneamente), o in tempi diversi (successivamente)[18].
- Il tempo è una rappresentazione necessaria, che sta a base di tutte le intuizioni. Non si può, rispetto ai fenomeni in generale, sopprimere il tempo, quantunque sia del tutto possibile toglier via dal tempo tutti i fenomeni. Il tempo dunque è dato a priori. Soltanto in esso è possibile qualsiasi realtà dei fenomeni. Questi possono sparir tutti, ma il tempo stesso (come condizione universale della loro possibilità) non può esser soppresso.
- Su questa necessità a priori si fonda anche la possibilità di princìpi apodittici[19] dei rapporti di tempo, o assiomi del tempo in generale. Esso ha una sola dimensione; diversi tempi non sono insieme, ma successivi (come diversi spazi non sono successivi, ma insieme). Questi princìpi non possono esser desunti dall’esperienza, perché questa non potrebbe darci né universalità rigorosa, né certezza apodittica. Potremmo dire soltanto: così ci dice la percezione comune, ma non: così deve essere. Questi principi valgono come leggi per le quali è possibile l’esperienza in generale, e ci istruiscono prima, non per mezzo di essa[20].
- Il tempo non è un concetto discorsivo o, come si dice, universale, ma una forma pura dell’intuizione sensibile. I diversi tempi non sono se non parti appunto dello stesso tempo. Ma la rappresentazione che non può esser data se non per un solo oggetto, si chiama, intuizione. Inoltre, la proposizione che tempi diversi non possono essere insieme non si potrebbe dedurre da un concetto universale. Questa proposizione è sintetica, e non può essere dedotta solo da concetti. È dunque immediatamente contenuta nell’intuizione e rappresentazione del tempo.
- L’infinità del tempo non significa se non che tutte le quantità determinate di tempo sono possibili solo come limitazioni di un tempo unico, che stia a loro fondamento.
Quindi la rappresentazione originaria tempo deve essere data senza limitazioni. Ma quando le parti stesse e ogni grandezza di un oggetto non si possono rappresentare determinate se non mediante una limitazione, allora la rappresentazione totale non può esser data mediante concetti (perché essi non contengono se non rappresentazioni parziali), ma a fondamento di esse deve esserci un’intuizione immediata[21].
Esposizione trascendentale del concetto del tempo
Posso per ciò rinviare al n. 3, dove, per esser breve, ho detto tra gli articoli della esposizione metafisica quello che propriamente è trascendentale. Qui soggiungo ancora, che il concetto del cangiamento, e con esso, il concetto del movimento (come cangiamento di luogo), è possibile solo mediante la rappresentazione del tempo; che, se questa rappresentazione non fosse intuizione (interna) a priori, nessun concetto, quale che sia, potrebbe rendere intelligibile la possibilità d’un cangiamento, cioè dell’unione in uno e medesimo oggetto di predicati opposti contraddittori (per es., l’essere e il non essere una stessa cosa nello stesso luogo). Solo nel tempo, ossia una dopo l’altra, possono incontrarsi insieme in una cosa due determinazioni opposte contraddittorie. Il nostro concetto del tempo spiega dunque la possibilità di tante conoscenze sintetiche a priori, quante ce ne propone la teoria generale del moto, che non ne è poco feconda[22].
Corollari di questi concetti
- a) Il tempo non è qualcosa che sussista per se stesso, o aderisca alle cose, come determinazione oggettiva, e che perciò resti, anche astrazion fatta da tutte le condizioni soggettive della intuizione di quelle: perché nel primo caso sarebbe qualcosa che, senza un oggetto reale, sarebbe tuttavia reale. Per quanto riguarda il secondo caso, come determinazione o ordine inerente alle cose stesse, non potrebbe precedere gli oggetti come loro condizione, ed esser conosciuto e intuito a priori per mezzo di proposizioni sintetiche. Ciò che invece ha luogo, se il tempo non è altro che la condizione soggettiva per cui tutte le intuizioni possono accadere in noi. Giacché allora questa forma delle intuizioni interne può essere rappresentata a priori, cioè prima degli oggetti.
- b) Il tempo non è altro che la forma del senso interno, cioè dell’intuizione di noi stessi e del nostro stato interno. Infatti, il tempo non può essere una determinazione di fenomeni esterni: non appartiene né alla figura, né al luogo, ecc.; determina, al contrario, il rapporto delle rappresentazioni nel nostro stato interno. E appunto perché questa intuizione interna non ha nessuna figura, noi cerchiamo di supplire a questo difetto con analogie, e rappresentiamo la serie temporale con una linea che si prolunghi all’infinito, nella quale il molteplice forma una serie avente una sola dimensione; e dalle proprietà di questa linea argomentiamo tutte quelle del tempo, fuorché questa sola; che le parti della linea sono simultanee, laddove le parti del tempo sempre successive. Da ciò risulta che la rappresentazione del tempo stesso è un’intuizione, poiché tutti i suoi rapporti possono essere espressi per mezzo di un’intuizione esterna.
- c) Il tempo è la condizione formale a priori di tutti i fenomeni in generale. Lo spazio, essendo la forma pura di tutte le intuizioni esterne, è limitato, come condizione a priori, ai soli fenomeni esterni. Invece, poiché tutte le rappresentazioni – abbiano o no oggetti esterni – pure in se stesse, quali modificazioni dello spirito, appartengono allo stato interno; e poiché questo stato interno rientra sotto la condizione formale dell’intuizione interna, e però del tempo; così il tempo è condizione a priori di ogni fenomeno in generale; condizione, invero, immediata dei fenomeni interni (dell’anima nostra), e però mediatamente anche degli esterni. Se posso dire a priori: tutti i fenomeni esterni sono determinati a priori nello spazio e secondo relazioni spaziali; posso anche, movendo dal principio del senso interno, dire universalmente: tutti i fenomeni in generale, cioè tutti gli oggetti dei sensi, sono nel tempo, e stanno fra di loro necessariamente in rapporti di tempo[23].
Se noi facciamo astrazione dalla nostra maniera di intuire internamente noi stessi e di cogliere mediante codesta intuizione anche le intuizioni esterne nella facoltà rappresentativa, e consideriamo quindi gli oggetti come qualcosa per sé stante, il tempo non è più nulla. Esso ha validità oggettiva soltanto rispetto ai fenomeni, poiché i fenomeni sono già cose che noi assumiamo come oggetti del nostro senso; ma non è più oggettivo, se si astrae dalla sensibilità della nostra intuizione, e perciò dal modo di rappresentare che ci è proprio, e si parla di cose in generale. Il tempo è dunque unicamente condizione soggettiva della nostra (umana) intuizione (che è sempre sensibile, cioè in quanto noi veniamo modificati da oggetti), e non è nulla in se stesso, fuori del soggetto. Ciò nonostante, rispetto a tutti i fenomeni, quindi anche a tutte le cose, che ci si possono presentare nell’esperienza, esso è necessariamente oggettivo. Non possiamo dire: tutte le cose sono nel tempo, perché, nel concetto delle cose in generale, si fa astrazione da ogni specie di intuizione delle medesime, laddove questa è la condizione speciale per cui il tempo entra nella rappresentazione degli oggetti. Ma, aggiungendo a quel concetto la condizione, e dicendo: «tutte le cose, in quanto fenomeni (oggetti dell’intuizione sensibile), sono nel tempo», il principio acquista la sua oggettiva legittimità e universalità a priori.
Le nostre osservazioni dimostrano quindi la realtà empirica del tempo, cioè la sua validità obbiettiva rispetto a tutti gli oggetti, che possano mai esser dati ai nostri sensi. E poiché la nostra intuizione è sempre sensibile, così non può esserci dato mai nell’esperienza un oggetto, che non sia soggetto alla condizione del tempo. Per contro noi contestiamo al tempo ogni pretesa a realtà assoluta, nel senso che, anche indipendentemente dalla forma della nostra intuizione sensibile, inerisca assolutamente alle cose come loro condizione o qualità. Tali proprietà, spettanti alle cose in sé, non potranno mai esserci date mediante i sensi. In ciò dunque consiste l’idealità trascendentale del tempo, secondo la quale esso non è niente, ove si prescinda dalle condizioni soggettive dell’intuizione sensibile, e non può esser considerato né come sussistente né come inerente agli oggetti in se stessi (senza rapporto alla nostra intuizione). Tuttavia questa idealità, al pari di quella dello spazio, non può essere paragonata ai dati surrettizi delle sensazioni, poiché lì il fenomeno stesso, cui tali predicati ineriscono, si suppone sempre che abbia quella realtà oggettiva, che qui vien del tutto a mancare, salvo che come semplicemente empirica, cioè riguardante l’oggetto stesso come semplice fenomeno: su di che è da rivedere sopra l’osservazione della sezione precedente[24].
Chiarimento
[ … ] Tempo e spazio sono pertanto due fonti del conoscere, dalle quali possono essere attinte a priori varie conoscenze sintetiche, come segnatamente ce ne dà uno splendido esempio la matematica pura, rispetto alla conoscenza dello spazio e de’ suoi rapporti. Essi cioè sono, tutti due, forme pure di tutte le intuizioni sensibili; e così rendono possibili proposizioni sintetiche a priori[25]. Ma queste fonti a priori della conoscenza, si determinano da sé proprio perciò (che sono semplicemente condizioni della sensibilità) i loro confini: cioè si riferiscono agli oggetti, solo in quanto questi son considerati come fenomeni, ma non rappresentano cose in sé. Solo quelli sono il campo della loro validità, fuori del quale, ove se ne esca, non c’è più uso oggettivo di esse. Questa realtà dello spazio e del tempo, del resto, ci lascia intatta la sicurezza della conoscenza sperimentale; perché noi ne siamo ugualmente certi, o che queste forme appartengano alle cose in sé, o solo alla nostra intuizione di queste cose in un modo necessario. Al contrario, coloro che affermano la realtà assoluta dello spazio e del tempo, la considerino come sussistente o soltanto come inerente, vengono di necessità a contraddire ai princìpi dell’esperienza. Giacché, se si risolvono per la prima ipotesi (ch’è comunemente il partito dei fisici matematici), devono ammettere due non-enti (spazio e tempo) come eterni ed infiniti, aventi una realtà per sé; che (pur non essendo niente di reale) esistono solo per contenere in sé tutto il reale. Se prendono il secondo partito (che è quello di alcuni fisici metafisici), e spazio e tempo valgono per loro come rapporti dei fenomeni (giustapposizione o successione), astratti dall’esperienza, benché confusamente rappresentati in tale astrazione: essi debbono negare alle teorie a priori della matematica rispetto alle cose reali (per es. nello spazio) la loro validità, o almeno la certezza apodittica, poiché quest’ultima non c’è punto a posteriori, e i concetti a priori di spazio e di tempo, secondo questa opinione, vengono ad essere solo creature dell’immaginazione; la fonte delle quali, in realtà, va cercata nell’esperienza, dai cui rapporti astratti l’immaginazione ha composto qualcosa, che contiene ciò che in essi v’è di generale, ma che non può esistere senza le limitazioni che la natura ha con essi congiunte. I primi ci fanno il guadagno di rendersi libero il terreno dei fenomeni per le affermazioni matematiche. Al contrario, si smarriscono per causa di queste stesse condizioni, quando l’intelletto vuol andare al di là di cotesto terreno. I secondi in confronto ci guadagnano di più, cioè non capitano loro incontro le rappresentazioni di spazio e tempo se vogliono giudicare degli oggetti non come fenomeni, ma solo in rapporto coll’intelletto; ma essi non possono né giustificare (poiché loro manca una intuizione a priori, vera ed oggettivamente valida) la possibilità di conoscenze matematiche a priori, e né anche mettere le proposizioni sperimentali in un accordo necessario con quelle affermazioni. Nella nostra teoria la vera natura di quelle due forme originarie del senso toglie di mezzo entrambe le difficoltà[26].
- Kant, Critica della ragion pura, trad. it. di G. Gentile e L. Lombardo Radice, Laterza, Roma-Bari 1977, vol. I, pp. 74-79,81-82
LESSICO
Oggettivo / Soggettivo
In un primo significato fondamentale, le espressioni oggettivo e soggettivo indicano ciò che si riferisce, rispettivamente, all’oggetto e al soggetto della conoscenza. Quando si parla di qualità oggettive, ad esempio, si intendono quelle caratteristiche che si ritengono appartenere effettivamente all’oggetto, come le sue dimensioni spaziali; mentre si definiscono soggettive le qualità che si crede non esistano nell’oggetto, bensì, appunto, nel soggetto, quale risultato delle modificazioni prodotte in esso dall’azione dell’oggetto. In altre parole, mentre le prime dovrebbero riguardare l’oggetto come è, le seconde si riferiscono all’oggetto come ci appare. A questo primo significato, tuttavia, tende a sovrapporsene un altro. Oggettivo significherà allora assoluto, soggettivo, invece, indicherà ciò che è relativo. La connessione fra queste due coppie di significati è evidente. Ciò che appartiene all’oggetto, infatti, non varierà a seconda del soggetto che tale oggetto percepisce o pensa: sarà quindi assoluto e valido universalmente. Viceversa, ciò che dipende dalle modalità conoscitive del soggetto potrà variare a seconda del singolo individuo che conosce la realtà: sarà dunque relativo. Ma tale connessione, pur evidente e in qualche misura legittima, può ingenerare confusione. In primo luogo, infatti, l’espressione soggettivo non indica necessariamente che le modalità percettive e conoscitive variano da individuo a individuo; essa può infatti riferirsi non già al singolo soggetto, bensì al soggetto in generale, sottolineando il fatto che l’uomo non potrà mai conoscere gli oggetti come sono, ma sempre soltanto come gli appaiono, senza tuttavia escludere che, essendo le strutture conoscitive sostanzialmente simili in tutti gli uomini, tutti gli uomini conoscano la realtà fondamentalmente allo stesso modo. Quando Protagora, ad esempio, sostiene che l’uomo è misura di tutte le cose, certamente intende dire che le cose appaiono diversamente a diversi individui, ma, con ogni probabilità, vuole anche dire che l’uomo, in generale e in quanto tale, conosce la realtà non per quella che è, ma per come le proprie strutture conoscitive gli consentono di coglierla. Da questo punto di vista, ciò che è soggettivo sarà certo relativo nel senso che dipende dagli strumenti conoscitivi del soggetto, ma non necessariamente nel senso che varia da individuo a individuo. Kant, ad esempio, pur ammettendo che noi conosciamo il mondo non come è ma come ci appare, riterrà che, essendo identiche in ogni uomo le forme della conoscenza, essa ha comunque un valore universale. Anzi, il fatto che la conoscenza dipenda da forme identiche in tutti i soggetti è propriamente, per lui, ciò che ne fonda l’oggettività. Al punto che, forzando un po’ l’uso consueto dei termini, potrà affermare che la conoscenza dell’uomo è oggettiva, non certo perché attinga gli oggetti come sono in sé, cosa che egli ritiene impossibile, ma perché possiede, appunto, un valore universale e necessario. Con un apparente paradosso si potrebbe affermare che per Kant la conoscenza risulta oggettiva (cioè universale e necessaria) proprio perché è soggettiva (in quanto si fonda su forme conoscitive identiche in tutti i soggetti). Per quanto riguarda la questione del tempo, queste precisazioni sul significato dei termini soggettivo e oggettivo ci permettono di illuminare i rapporti fra le concezioni di Newton, Leibniz e Kant su tale argomento. Per Newton il tempo e lo spazio sono oggettivi in un duplice senso. Da un lato, infatti, il tempo è oggettivo e non soggettivo, nel senso che non è un nostro modo di percepire gli oggetti bensì riguarda la loro effettiva esistenza; dall’altro è oggettivo nel senso di assoluto, in quanto non dipende dall’esistenza degli enti in esso contenuti e, anzi, concettualmente li precede. Anche per Leibniz il tempo e lo spazio sono oggettivi nel senso che non dipendono dalle strutture conoscitive del soggetto e ineriscono effettivamente alla realtà; essi, tuttavia, sono relativi in quanto si configurano, rispettivamente, come ordine delle successioni e delle coesistenze degli oggetti. Kant, la cui formazione risente dell’influenza del pensiero leibniziano, finirà, sulla questione del tempo e dello spazio, per sposare le tesi newtoniane, pur modificandole in un punto fondamentale. L’esigenza principale di Kant, come già di Newton, è quella di dare dei quadri di riferimento stabili alla conoscenza scientifica della realtà: in questo senso, l’ammissione di uno spazio e di un tempo assoluti gioca un ruolo fondamentale. Tuttavia, ciò che in tale prospettiva è indispensabile garantire non è tanto l’indipendenza dello spazio e del tempo dal soggetto conoscitivo, quanto piuttosto un carattere universale che consenta di attribuire loro il ruolo di terreno comune dell’esperienza. Kant, ritenendo di poter fondare l’universalità dello spazio e del tempo solo considerandoli come forme della conoscenza identiche in tutti i soggetti, rinuncerà quindi alla loro oggettività nel senso di indipendenza dal soggetto conoscente, per poterne recuperare l’oggettività nel senso, appunto, della loro universalità e anteriorità concettuale rispetto agli oggetti. Da Newton – e contro Leibniz – Kant accetta, insomma, l’idea che tempo e spazio siano indipendenti dagli oggetti e che, anzi, gli enti fisici esistano e siano pensabili solo in quanto si presuppongono già uno spazio e un tempo in cui possano essere contenuti; ma da Newton lo separa la convinzione che, per poter fare dello spazio e del tempo la condizione dell’esistenza degli oggetti fisici, sia necessario rinunciare a una loro esistenza che non sia quella di forme della nostra conoscenza. Gli oggetti esistenti nello spazio e nel tempo, pertanto, non saranno le cose in sé, bensì solamente le cose come appaiono a noi, che Kant chiamerà fenomeni. In conclusione e in forma schematica si potrebbe affermare che per Newton spazio e tempo sono indipendenti tanto dal soggetto quanto dall’oggetto; per Leibniz sono dipendenti dall’oggetto e indipendenti dal soggetto; per Kant, infine, sono indipendenti dall’oggetto (inteso come oggetto fenomenico), ma dipendenti dal soggetto (inteso come soggetto conoscente in generale e non come singolo individuo). Non dimentichiamo, comunque, che dall’antichità fino all’età contemporanea vi sono stati pensatori che hanno collegato il tempo proprio alla dimensione dell’interiorità e della soggettività individuale: si pensi, ad esempio, alle riflessioni di Seneca (v. T 13), di Agostino (v. T 16) o dello stesso Bergson.
[1] La genesi del pensiero spinoziano è in gran parte riconducibile all’esigenza di risolvere il fondamentale dualismo postulato dalla metafisica di Cartesio. Il filosofo francese, infatti, aveva ammesso due tipi di sostanza radicalmente differenti, il pensiero, o res cogitans, e l’estensione, o res extensa: il primo caratterizzato in termini di pura spiritualità, la seconda altrettanto puramente materiale. Questo dualismo, tuttavia, generava una serie di contraddizioni che risultavano difficilmente superabili. Si trattava, in definitiva, di spiegare come queste due realtà così irriducibilmente differenti potessero in qualche modo interagire fra loro, o comunque corrispondersi nei rispettivi stati. Come avviene, ad esempio, che, quando voglio alzare il braccio, il mio braccio effettivamente si alza? Il fatto è tanto comune da apparire, di primo acchito, privo di difficoltà e assolutamente ovvio. Tuttavia, se appena ci riflettiamo, esso risulta assai problematico. La mia volontà di alzare il braccio, infatti, secondo la prospettiva cartesiana, è uno stato della coscienza, un evento spirituale; e, dal momento che, sempre secondo tale prospettiva, il mondo materiale è un puro meccanicismo in cui i corpi agiscono gli uni sugli altri per contatto, bisognerebbe ipotizzare che, in qualche maniera misteriosa, il nostro spirito potesse spingere o tirare il nostro corpo in modo da fargli compiere determinati movimenti. Simmetricamente, nel caso della sensazione, sarebbe necessario ammettere che stimoli corporei estremi, trasmessi per contatto attraverso i nervi, potessero in ultima istanza anch’essi spingere o tirare l’anima e generare in essa quelle modificazioni che chiamiamo percezioni. Ed è proprio ciò che ammise Cartesio, individuando nella cosiddetta ghiandola pineale, posta in prossimità della base del cervello, il luogo in cui fatti materiali del corpo umano e fatti spirituali dell’anima possono incontrarsi e influenzarsi reciprocamente. E tuttavia, la spiegazione cartesiana risulta assai poco convincente, perché ipotizza una relazione difficilmente accettabile fra due ordini di realtà troppo eterogenei. In effetti, che tale spiegazione fosse insoddisfacente, è ampiamente confermato dal fatto che gran parte della riflessione filosofica fra la metà del Seicento e l’inizio del secolo successivo si incentrò sul tentativo di fornire una soluzione migliore del problema sollevato ma non risolto dal filosofo francese. Spinoza intervenne nel dibattito con una soluzione di grande semplicità ed efficacia, che può essere così sintetizzata: se è impossibile stabilire una relazione fra le due sostanze cartesiane, la cosa più semplice è negare che si tratti effettivamente di due sostanze. In definitiva, infatti, Spinoza riduce quelle che Cartesio considerava due tipi di sostanze radicalmente distinte ad attributi differenti dell’unica sostanza davvero degna di questo nome, quella divina. Cartesio, per poter ammettere che tanto la materia quanto lo spirito finito dell’uomo fossero sostanze, aveva dovuto forzare la stessa tradizionale definizione di sostanza di origine aristotelica: se, infatti, dovessimo riconoscere come sostanza soltanto ciò che per esistere ed essere pensato non ha bisogno di null’altro che di se stesso, allora le realtà create che dipendono da Dio non potrebbero rientrare nella definizione. Cartesio, pertanto, la corregge, ammettendo che sia sostanza tutto ciò che per esistere ed essere pensato non ha bisogno di null’altro fuori di sé, fatta eccezione che di Dio. Spinoza avrà così buon gioco a riprendere la definizione originale contro quella corretta da Cartesio, giungendo così ad ammettere che Dio è l’unica sostanza e che i due tipi di sostanza ammessi da Cartesio ne sono soltanto attributi, mentre le singole cose si configurano nel suo pensiero come puri modi, cioè modificazioni dell’unica sostanza divina. In realtà, il rigoroso monismo spinoziano, cioè, appunto, la sua riduzione dell’intera realtà a un’unica sostanza, ha numerose fonti, che egli fonde con grande originalità in una potente sintesi speculativa. In primo luogo, deve essere citata l’origine ebraica di Spinoza: dalla tradizione religiosa ebraica egli trae, infatti, l’insistenza sull’unità e unicità della divinità. In secondo luogo, bisogna ricordare la speculazione neoplatonica tardoantica e rinascimentale, dalle riflessioni di Plotino sui modi in cui l’assoluta unità del principio si rifrange nell’indefinita molteplicità della realtà che ne deriva; alla tendenziale identificazione operata da Giordano Bruno fra Dio e natura. Lo stoicismo, infine, forniva a Spinoza l’immagine di un mondo totalmente permeato dalla presenza immanente di una divina razionalità che si esprime in un rigido determinismo: solo riconoscendo tale perfetta razionalità e adeguandovisi l’uomo potrà acquistare la virtù e con essa la felicità. Ma dall’ebraismo lo spinozismo si distingue per un radicale immanentismo che stride con l’idea veterotestamentaria dell’assoluta trascendenza di Dio. Da Plotino lo separa il fatto che mentre in quest’ultimo l’Uno, il principio assoluto, genera la realtà facendola uscire, per così dire, da se stesso, in Spinoza l’infinita molteplicità della realtà non è altro che l’autoarticolarsi interno dell’unica sostanza rispetto allo stoicismo, la distanza è segnata dal fatto che, se per quest’ultimo la divina razionalità permea il mondo, essa ne rappresenta, però, soltanto l’aspetto formale, dal quale deve essere distinta la materia che da tale razionalità è governata, laddove per Spinoza la stessa materia è un attributo dell’unica sostanza. Anche rispetto al pensiero bruniano, infine, che per molti aspetti è quello più vicino alla concezione di Spinoza, una differenza significativa consiste nel fatto che solamente in quest’ultima la derivazione dei modi dalla sostanza divina assume un aspetto esplicitamente matematico.
[2] L’Etica inizia con otto definizioni che costituiscono il punto di partenza di tutta l’argomentazione successiva. La principale di esse è probabilmente la sesta, la quale ribadisce una definizione di sostanza risalente in ultima istanza ad Aristotele per trarne, tuttavia, alcune conclusioni apparentemente paradossali e comunque in contrasto sia con il senso comune sia con la maggior parte delle filosofie precedenti e contemporanee all’autore. Se sostanza è in senso stretto solamente ciò che per esistere e per essere pensato non ha bisogno di null’altro all’infuori di sé, allora, a rigore, non potranno essere sostanze quelle che comunemente consideriamo tali, dal momento che ogni singolo ente sembra sempre avere, in altro la ragione della propria esistenza. Sostanza, allora, potrà essere solo qualcosa che possa essere concepito come causa di se stesso, caratteristica riferibile solamente a Dio. Se dunque solo Dio è autentica sostanza, come dovremo chiamare quelle che abitualmente indichiamo con tale appellativo? I vari tipi di sostanza che il senso comune e la filosofia hanno individuato, quali la res cogitans e la res extensa ipotizzate da Cartesio, cioè il pensiero e la materia estesa, si riducono, nel pensiero di Spinoza, a semplici attributi, ovvero aspetti differenti della sostanza. Essi sono infiniti di numero, anche se noi ne conosciamo soltanto due. Nella sua unicità, l’autentica sostanza non può essere limitata da alcunché e sarà quindi infinita. Infiniti di numero e di grandezza saranno quindi anche i suoi attributi, benché in questo caso si tratterà solamente di un’infinità relativa, mentre quella assoluta competerà soltanto alla sostanza: il corpo sarà infinito quanto a estensione spaziale e il pensiero lo sarà nel suo genere; ma solamente Dio è infinito sotto ogni aspetto. Quanto ai singoli enti, che rappresentavano per Aristotele le sostanze per eccellenza, essi non saranno altro che modi dell’unica sostanza divina, cioè sue particolari modificazioni, che da essa derivano e solo in riferimento ad essa possono essere concepiti. In che maniera dalla sostanza derivano gli infiniti modi secondo i suoi infiniti attributi? Spinoza chiarisce che la sostanza è libera e non necessaria. Ma per lui questo vuol dire solamente che essa esiste e si comporta secondo la propria natura e non costretta da qualcosa che le è estraneo: e, d’altra parte, che cosa potrebbe costringere la sostanza che è l’unica realtà esistente? La contrapposizione, quindi, non è tanto fra libertà e necessità, quanto piuttosto fra libertà e coazione: nel suo essere perfettamente determinata dalla propria natura, la sostanza è a un tempo totalmente necessitata e pienamente libera. È dunque questa attività in cui libertà e necessità si identificano quella attraverso cui gli infiniti attributi e gli infiniti modi derivano dalla sostanza. La sostanza, poi, come causa di sé, è senz’altro eterna, nel senso che essa esiste come conseguenza necessaria della sua stessa definizione. Questa stretta connessione fra eternità e necessità indica che, in un processo concepito come rigidamente necessario, in verità il tempo non esiste, in quanto il presente era già totalmente implicito nel passato e ha già in sé, a sua volta, tutto quanto si verrà sviluppando nel futuro. Spinoza chiarisce quindi immediatamente che l’eternità non può essere concepita come durata temporale senza principio né fine, ma deve essere intesa come radicalmente atemporale.
[3] Si chiarisce qui ulteriormente il rapporto fra necessità ed eternità. Spinoza riconosce tre livelli di conoscenza. Il primo livello è quello della conoscenza che egli definisce inadeguata, identificabile in sostanza con la conoscenza sensibile e immaginativa, che concepisce le cose nella loro slegata individualità e quindi come contingenti, non riuscendo ancora a cogliere i nessi necessari che le legano reciprocamente. Il secondo e il terzo livello sono quelli propri della conoscenza razionale. Il secondo è già una forma di conoscenza adeguata e consiste nella capacità di cogliere, al di là della singolarità e della contingenza, gli elementi comuni ai vari enti, cioè, in definitiva, nella capacità di ragionare in termini universali e necessari, individuando, in particolare, i rigorosi rapporti di causa ed effetto che governano la realtà. Ma è soltanto nel terzo livello che si perviene a concepire la totalità della realtà nella sua più autentica natura, come necessaria derivazione dall’unica sostanza di infiniti modi secondo infiniti attributi. La presunta contingenza dei singoli enti, cioè il loro poter esistere ma anche non esistere, è dunque soltanto il risultato di una maniera inadeguata di concepirli: essa trascura i legami necessari che intercorrono fra essi e che, soprattutto, li riconducono tutti all’unica sostanza. Solo se considerato nel suo illusorio isolamento ogni singolo ente può essere concepito come contingente; ma nel momento in cui viene inteso correttamente dalla ragione come un modo, una modificazione necessaria della sostanza, esso risulta del tutto necessitato. Nella sua assoluta perfezione, infatti, la sostanza divina opera in forma deterministica qualsiasi scostamento dal suo agire effettivo, per definizione perfetto, risulterebbe incompatibile con l’assoluta razionalità della sostanza. La ragione non è solo la facoltà che, genericamente, ci permette di cogliere l’intera realtà in termini necessari e non contingenti; ma si esprime anche nella rigida necessità di tipo matematico con cui gli attributi e i modi, cioè le singole cose, hanno origine dalla sostanza: essi ne derivano come i teoremi relativi al triangolo derivano dalla stessa sua definizione. Come si è già notato, l’uso del metodo matematico non esprime soltanto la scelta di una modalità particolarmente efficace di conoscenza della realtà: esso è, anzi, efficace perché riproduce la struttura stessa della realtà. Nel secondo corollario si chiarisce che concepire le cose come necessarie significa pensarle sotto l’aspetto dell’eternità. Infatti, come si è visto, il secondo e, soprattutto, il terzo livello della conoscenza inquadrano le singole cose come derivate necessariamente dall’unica sostanza e, con ciò stesso, le vedono non nel loro apparente dispiegarsi nel tempo, ma piuttosto nel loro identificarsi, in ultima istanza, con l’eterna natura divina. D’altra parte, si è già chiarito che i livelli razionali della conoscenza colgono le cose non nella loro singolarità, bensì nei loro caratteri comuni e universali, che, per definizione, sono fuori dal tempo: i singoli triangoli, ad esempio, fino a quando li si prende come tali, saranno collocabili nel tempo, ma i loro aspetti comuni, cioè, in definitiva, la nozione universale del triangolo, dovranno necessariamente essere concepiti come eterni. C.V.D. sta per “Come Volevasi Dimostrare”.
[4] Ancora una chiarificazione sul rapporto tempo-eternità. Ogni singolo ente, in quanto modo della sostanza sotto un determinato attributo, se adeguatamente concepito implica un riferimento all’eterna essenza di Dio. Nello scolio della proposizione XLV si precisa che l’esistenza degli enti non deve essere intesa come l’esistenza che compete loro in quanto singole realtà colte nella loro reciproca separatezza, bensì come l’esistenza che inerisce a esse in quanto derivano necessariamente dall’unica ed eterna sostanza divina. Quest’ultima forma di esistenza non sarà quindi calata nella durata temporale, ma dovrà essa stessa essere concepita sub specie aeternitatis, sotto l’aspetto dell’eternità. In effetti, da un certo punto di vista, ogni singolo ente è determinato a esistere da un altro singolo ente secondo la concatenazione causale: questo fatto permette di considerarlo collocato in una sequenza temporale, anche se non si deve dimenticare che, a ben vedere, è lo stesso rigido determinismo del rapporto di causalità meccanicistico che tende ad abolire la temporalità, giacché, come si è notato, in tale concezione si ammette che il passato abbia già in sé tutti gli elementi del presente e che questo, a sua volta, prefiguri totalmente gli avvenimenti futuri. Ma se passiamo al terzo livello della conoscenza, in cui tutti i modi vengono concepiti come derivanti necessariamente, secondo gli infiniti attributi, dall’unica sostanza, allora quelle stesse determinazioni particolari della sostanza devono essere pensate nella medesima eternità cui appartiene quest’ultima. Per chiarire questo passaggio può essere utile riferirsi, ancora una volta, all’immagine del triangolo. I teoremi che ineriscono a questa figura geometrica ne derivano necessariamente e fuori del tempo: essi sono quasi un’eterna autoarticolazione interna dell’essenza del triangolo. Tuttavia, quando lo studioso di geometria dimostra i singoli teoremi, effettua tale operazione attraverso una serie di passaggi: nessuno, però, dal fatto che il matematico deduce i teoremi secondo una sequenza che si svolge nel tempo, argomenterebbe che anche la loro effettiva derivazione dall’essenza del triangolo sia un processo temporale. Insomma, la derivazione oggettiva dei teoremi dal triangolo è atemporale, cioè eterna, ma la deduzione che soggettivamente ne fa il matematico si svolge nel tempo. Così, dal momento che per Spinoza i modi derivano dalla sostanza nella medesima maniera in cui i teoremi derivano dal triangolo, si potrà dire che tale derivazione avviene di per sé fuori dal tempo, ma viene concepita in termini di durata temporale nelle sequenze causali colte dal secondo livello della conoscenza e, ancor più, nella conoscenza sensibile e inadeguata di primo livello. Tale modo di interpretare la realtà è, tuttavia, sostanzialmente illusorio; una conoscenza davvero adeguata di essa non potrà che farcela pensare, nella sua totalità e in tutti i suoi particolari, sub specie aeternitatis. In ultima istanza, è possibile affermare che, per Spinoza: il tempo, propriamente non esiste.
[5] Il radicale monismo spinoziano risulta fondamentale anche rispetto al problema del rapporto fra tempo ed eternità. Anche in questo caso, come in quello già considerato del rapporto fra res cogitans e res extensa, la soluzione consiste nel tagliare alla radice il problema stesso. Lì si trattava di negare la sostanzialità della materia e del pensiero riducendo entrambi ad attributi differenti dell’unica sostanza e risolvendo in questo modo la questione della reciproca corrispondenza dei loro stati: quando voglio alzare il braccio, esso si alza perché quell’atto di volontà e quel movimento sono un unico e medesimo modo della sostanza concepito ora sotto l’aspetto del pensiero, ora sotto quello dell’estensione. Anche il problema del tempo e del suo rapporto con l’eternità, fino a quando si rimane in una prospettiva dualistica, non è di facile soluzione e rischia di condurre all’inevitabile ammissione di un paradosso irresolubile per la ragione umana. Una volta riconosciuta, infatti, l’esistenza di due livelli della realtà, il primo, assoluto e divino, caratterizzato dalla dimensione dell’eternità, il secondo, relativo e sensibile, caratterizzato dalla temporalità, la questione del rapporto fra eternità e tempo si pone con urgenza e non è priva di difficoltà. Le soluzioni possibili sono allora essenzialmente due, o si ipotizza, come in Platone (vedi T 10) e, in ultima istanza, anche in Aristotele, un rapporto di imitazione del tempo nei confronti dell’eternità; oppure si deve ammettere, come nella tradizione ebraico- cristiana, un paradossale inserimento dell’eternità nel tempo e, come si è visto, del tempo nell’eternità. Anche in questo caso, la soluzione proposta da Spinoza è geniale nella sua semplicità. Come i singoli enti che costituiscono il mondo non esistono in quanto autentiche sostanze, ma solo come modi della sostanza divina; così anche alla durata temporale, cioè alla dimensione loro propria, non si può attribuire un’effettiva realtà. Se concepire i modi come sostanze è soltanto il risultato di un errore di prospettiva che ci impedisce di coglierne la derivazione dall’autentica sostanza; anche il tempo, allora, ha un’esistenza sostanzialmente illusoria, che svanisce non appena le singole cose vengono colte, in quanto modi derivanti con necessità deterministica dall’essenza della sostanza, sub specie aeternitatis. Se, insomma, esiste, propriamente, la sola sostanza divina, allora si dovrà affermare che esiste soltanto la dimensione che la caratterizza, cioè l’eternità. Ancora una volta bisognerà quindi ammettere che, per Spinoza, il tempo è un’illusione e che, a rigore, non esiste.
[6] Newton non si propone di definire lo spazio e il tempo, che considera, forse un po’ sbrigativamente, come nozioni in sé sufficientemente chiare. Egli intende, piuttosto, distinguere nettamente il tempo e lo spazio relativi, di cui fa uso il senso comune, da quelli assoluti, che vengono utilizzati nell’ambito del discorso scientifico. In realtà, già questa semplice distinzione, con la sottolineatura del fatto che tempo e spazio possono essere concepiti in due differenti modi, sembrerebbe suggerire la non ovvietà di tali concetti. Per Newton il tempo vero, dunque, è di per sé assoluto, nel senso che la sua natura non risulta affatto modificata da eventuali enti in esso esistenti. Esso scorre uniformemente e tale flusso o durata non è in relazione alcuna con gli oggetti che vi sono immersi. Si noti che, un po’ paradossalmente, tali oggetti vengono qui definiti come esterni al tempo, a sottolineare l’assolutezza e l’indipendenza della durata rispetto a quelli. In altri termini, il tempo, in analogia con lo spazio, viene concepito come una sorta di recipiente, la cui natura non risulta influenzata dalla presenza o meno in esso di un contenuto, né dalle caratteristiche di tale contenuto. Il tempo relativo, al contrario, è quello che si calcola utilizzando come unità di misura determinati movimenti dotati di una certa regolarità: si pensi al giorno, misurato dal moto di rotazione della Terra intorno al proprio asse, o all’anno, individuato dal moto di rivoluzione del nostro pianeta intorno al sole.
[7] Rispetto al tempo relativo che il senso comune calcola con riferimento, ad esempio, all’alternarsi del giorno e della notte, gli scienziati sono in grado di operare significative correzioni utilizzando come misura i moti dei corpi celesti studiati dall’astronomia. Tuttavia, per quanto il tempo calcolato dall’astronomia sia molto più preciso di quello quotidianamente calcolato dall’uomo comune, anch’esso è per Newton soltanto un tempo relativo, misurato su determinati movimenti di alcuni corpi. Altra cosa resta il tempo vero, che continua a scorrere costantemente a differenza di qualsiasi movimento, che può subire accelerazioni e rallentamenti. In altre parole, se per ipotesi il moto della Terra subisse delle modificazioni, l’unità di misura del tempo e con essa il tempo relativo e apparente muterebbero anch’essi, ma il fluire del tempo assoluto non ne sarebbe minimamente modificato. Il fatto che, per rendere in qualche modo conto dello scorrere del tempo, dobbiamo calcolarlo in base al movimento di determinati corpi utilizzati come unità di misura, quindi, non ci deve portare a dimenticare la distinzione fra il tempo vero e assoluto e il tempo relativo che deriva dalla sua misurazione sensibile.
[8] La concezione dello spazio e del tempo come realtà assolute ha in Newton una duplice origine. Da un lato, infatti, egli è mosso dall’esigenza di individuare quadri di riferimento stabili entro i quali costruire una fisica matematizzata. Dall’altro, su un piano più strettamente storico, un antecedente di quella concezione si ha nelle teorie elaborate da un gruppo di pensatori inglesi del Seicento comunemente noti come “platonici di Cambridge” Essi, a loro volta, sviluppando spunti che risalivano a certi aspetti della tradizione cabalistica ebraica, avevano concepito lo spazio e il tempo non soltanto come qualcosa di molto reale, ma, addirittura, come una sorta di attributi di Dio.
Lo stesso Newton, in effetti, nell’Ottica, indica lo spazio come un sensorium Dei, quasi un organo o un mezzo attraverso il quale Dio crea, sente e conserva l’universo fisico. Il collegamento dello spazio e del tempo con Dio gli consentiva, ovviamente, di considerarli come qualcosa di tutt’altro che relativo: essi sono per lui i contenitori assoluti del reale, per alcuni versi più veri del loro stesso contenuto. In realtà, l’assolutizzazione del tempo e dello spazio e la loro quasi divinizzazione non sono prive di contraddizioni nel cotesto del pensiero di Newton. Il famoso motto dello scienziato e filosofo inglese, hypotheses non fingo, con cui si contrapponeva alla tendenza di Cartesio a sopportare le proprie affermazioni fisiche con incontrollabili postulati metafisici, potrebbe benissimo essere rivolto, in effetti, contro la concezione newtoniana del tempo e dello spazio, che poco ha a che fare con la pura elaborazione razionale dei dati empirici e dei risultati sperimentali e si configura, al contrario, come una vera e propria supposizione metafisica, se non addirittura teologica. In ogni caso, rispetto alle concezioni del tempo precedenti, quella newtoniana introduce significative novità.
In primo luogo, si deve sottolineare che, in qualche misura, nel pensiero greco così come nella riflessione cristiana il tempo era stato per lo più considerato come qualcosa di connesso a un livello o a uno stato inferiore della realtà, caratterizzato dalla transitorietà e dalla relatività, se non addirittura da una forma depotenziata di esistenza. In Newton la connotazione del tempo come attributo della divinità toglie ogni spazio a interpretazioni di questo genere.
In secondo luogo, nell’antichità il tempo era stato identificato con il moto dei corpi celesti o, comunque, con qualche aspetto di tale moto: lo scienziato inglese, al contrario, chiarisce senza ombra di dubbio che il movimento degli astri, come peraltro qualsiasi altro movimento, ha a che fare con la misurabilità sensibile del tempo, ma non con la sua essenza, che resta totalmente indipendente da essi. Non meno lontana è la posizione di Newton rispetto alle prospettive in qualche misura soggettivistiche anticipate da Aristotele (v. T 11) e approfondite da Agostino (v. T 16) ancora una volta, quel tanto di soggettività che può forse inerire alla percezione e al calcolo del tempo non riguarda affatto il tempo in quanto tale. In altri termini, il tempo scorre con costante e assoluta regolarità, indipendentemente tanto dagli oggetti che vi possono essere o non essere contenuti, quanto dai soggetti che percepiscono gli oggetti nel tempo e il tempo stesso.
Si potrebbe dire che, per Newton, se anche all’improvviso lo spazio e il tempo venissero svuotati di tutti gli oggetti in essi contenuti e, contemporaneamente, venisse meno qualsiasi soggetto in grado di percepire quegli oggetti, lo spazio continuerebbe a estendersi e il tempo a fluire senza alcun mutamento. La concezione newtoniana del tempo e dello spazio, pur contestata già all’epoca e messa fortemente in crisi anche dagli sviluppi della fisica contemporanea, ha permeato a tal punto la cultura moderna, e non solo quella scientifica, da essere ripresa nella sostanza non solo da Kant alla fine del Settecento, ma anche dal sentire comune dei secoli successivi fino a oggi: se riflettiamo sul modo in cui ciascuno di noi tende, spontaneamente e prima di qualsiasi considerazione scientifica o filosofica esplicita, a concepire lo spazio e il tempo, probabilmente ci accorgeremo di essere un po’ tutti “naturalmente” newtoniani. Si noti, infine, che la concezione del tempo viene elaborata da Newton in evidente analogia con quella dello spazio: entrambe le dimensioni, infatti, risultano per lui assolute; entrambe riguardano la realtà fisica di cui costituiscono, sia pure in due maniere differenti, quasi il contenitore; entrambe, infine, si configurano come estensioni omogenee e indifferenti rispetto ai loro effettivi contenuti.
Sotto questo aspetto, già Kant, con la sottolineatura delle differenze fra spazio e tempo, intesi rispettivamente come forma del senso esterno e di quello interno, segnerà un primo distacco dall’impostazione newtoniana, Ma sarà soprattutto Bergson a rivendicare l’irriducibile eterogeneità reciproca di spazio e durata reale.
[9] Leibniz incentra la sua dimostrazione della relatività dello spazio e del tempo sul principio di ragione sufficiente. Tale principio fondamentale, così denominato dallo stesso Leibniz, sostiene che nulla esiste o avviene senza che vi sia una causa o un motivo perché esista o avvenga, e proprio nella maniera determinata in cui esiste o avviene. Lo spazio reale e assoluto, caro ai newtoniani, viene definito un idolo, nel senso in cui Bacone aveva chiamato idoli quei pregiudizi che sovrapponiamo arbitrariamente alla realtà e che ci impediscono di interpretarla in modo corretto, Si noti che, per combattere una concezione particolarmente diffusa in Inghilterra, Leibniz cita, presumibilmente di proposito, quello che per molti versi era considerato il padre della tradizione empiristica inglese, Bacone appunto.
[10] Secondo Leibniz, il tempo e lo spazio non sono assoluti; ma, in quanto rispettivamente ordine delle successioni e delle coesistenze, vanno concepiti come relativi agli oggetti. In altre parole, mentre per Newton essi potevano essere immaginati quasi come recipienti nei quali potevano essere o non essere contenuti degli oggetti, rispetto ai quali erano concettualmente anteriori e che, comunque, non ne determinavano o influenzavano la natura; per Leibniz, solo una volta ipotizzati come esistenti degli oggetti se ne possono poi pensare le relazioni. Lo spazio, allora, sarà l’insieme delle relazioni che legano gli enti coesistenti, mentre il tempo sussisterà solo come insieme delle relazioni fra gli stati successivi di tali enti.
[11] Newton, propriamente, non aveva affermato che lo spazio è una sostanza; tuttavia, in quanto esso era per lui una sorta di attributo divino, lo aveva concepito come una realtà assoluta. Sostanza è, infatti, solamente ciò che per esistere non ha bisogno di null’altro all’infuori di sé: anche per Newton, quindi, lo spazio, pur assoluto e indipendente rispetto agli oggetti che vi sono contenuti, esiste soltanto in riferimento alla sostanza di Dio.
[12] Leibniz argomenta la relatività dello spazio attraverso una sorta di dimostrazione per assurdo fondata sul principio di ragione sufficiente. In uno spazio assoluto ipotizzato come esistente anche in assenza dei corpi, infatti, le parti risulterebbero perfettamente identiche le une alle altre; Dio, allora, non avrebbe avuto nessun motivo di far esistere, ad esempio, un corpo A e un corpo B nei luoghi rispettivi che, di fatto, essi occupano: avrebbe potuto, pur mantenendone le posizioni relative, collocarli uno nel luogo attualmente occupato dall’altro. Ma, se lo spazio è soltanto una relazione fra i corpi, le due situazioni ora descritte risulterebbero perfettamente uguali: invertendo le posizioni dei corpi, il loro ordine reciproco, e quindi lo spazio da essi occupato, rimarrebbero immutati. Pertanto, la stessa domanda sulla scelta di Dio non avrebbe alcun senso, in quanto non vi sarebbero in realtà alternative differenti tra cui scegliere. Se si ammette uno spazio assoluto, quindi, l’esistenza dei corpi nei loro luoghi effettivi risulta inspiegabile in quanto in contraddizione con il principio di ragione sufficiente mentre, nell’ipotesi di uno spazio relativo, la contraddizione si dissolve.
[13] Analogamente a quanto dimostrato a proposito dello spazio, anche nel caso del tempo, una volta che esso sia concepito come assoluto, cioè sussistente indipendentemente dall’esistenza di realtà temporali, diventa impossibile spiegare perché Dio abbia fatto esistere le cose in un determinato momento e non prima o dopo: la sua azione sarebbe priva di motivazioni e, quindi, sfuggirebbe al principio di ragione sufficiente. Ma se il tempo è soltanto l’ordine della successione fra gli stati degli oggetti, la medesima successione di eventi non risulterebbe affatto modificata da un’ipotetica anticipazione o posticipazione; sarebbe, perciò, assurdo chiedersi la motivazione della scelta di Dio fra situazioni apparentemente distinte, ma che in realtà sono una sola e medesima. Più semplicemente, non ha alcun senso chiedersi perché le cose non esistano prima o dopo la loro attuale collocazione temporale, dal momento che non esiste alcun tempo assoluto in cui potrebbero essere anticipate o posticipate: in particolare, quindi, non è mai esistito alcun tempo prima dell’esistenza delle cose.
[14] Alle argomentazioni di Leibniz si potrebbe opporre che la semplice volontà di Dio, anche in assenza di differenze oggettive fra le possibili alternative, sarebbe una ragione sufficiente della sua scelta. Ma Leibniz rifiuta questa idea dell’onnipotenza assoluta di Dio: affermare che egli sceglie senza un motivo che non sia la sua volontà vuol dire mettere in discussione la perfezione divina. Questa, infatti, come Leibniz aveva chiarito nella Teodicea, si esprime proprio nel fatto che, pur essendo Dio libero e non necessitato nel suo comportamento, egli agisce tuttavia secondo motivi ed è, anzi, obbligato moralmente a compiere la scelta oggettivamente migliore.
[15] Leibniz chiarisce che non si può parlare di una eternità del tempo e che fra i due concetti bisogna mantenere una netta distinzione. Infatti, non può essere eterno ciò che neppure esiste; non può esistere ciò di cui non esistono le parti, e le tre parti o dimensioni del tempo non esistono: il passato e il futuro, in quanto il primo non è più e il secondo non è ancora, il presente, in quanto si risolve in un istante privo di dimensioni. Si noti che, mentre altrove Leibniz sembra individuare le caratteristiche del tempo sulla base della sua analogia con lo spazio, qui avviene il contrario: dall’idealità, cioè non realtà, del tempo si deduce che anche lo spazio, che con il tempo pare presentare così strette analogie, dovrà essere altrettanto ideale.
[16] La netta distinzione fra eternità e tempo consente a Leibniz di confutare un’obiezione che si potrebbe muovere alla sua concezione della relatività del tempo. Contro chi sostenesse che, anche in assenza di oggetti, il tempo esisterebbe in quanto esisterebbe Dio che è in ogni tempo, Leibniz precisa che l’eternità di Dio non va intesa in questo modo, bensì nel senso che Egli sarebbe coesistente a qualunque oggetto che comunque esistesse. L’eternità di Dio si distingue dal tempo non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente e non si può ridurre a un’estensione all’infinito della durata che caratterizza gli enti creati.
[17] Sullo sfondo di queste pagine kantiane stanno le riflessioni di tre importanti pensatori che avevano operato tra la fine del Seicento e il Settecento. Si tratta di Leibniz e Hume. I primi due, come si è visto, si erano contrapposti reciprocamente, fra l’altro, per le concezioni radicalmente diverse dello spazio e del tempo. Per Newton, infatti, questi erano assoluti e indipendenti tanto dagli oggetti quanto dai soggetti conoscenti. Secondo Leibniz, al contrario, essi avevano sì un carattere oggettivo, nel senso che inerivano effettivamente agli oggetti e non erano soltanto un nostro modo di percepirli; la loro oggettività, tuttavia, consisteva solo nel non dipendere dai modi conoscitivi del soggetto e non comportava affatto l’essere realtà assolute rispetto agli oggetti, da cui anzi dipendevano, appartenendo loro come l’ordine e l’insieme delle loro reciproche relazioni. Rispetto alla questione della natura dello spazio e del tempo, Kant si schiera decisamente dalla parte di Newton. Già in uno scritto del 1768, Del primo fondamento della distinzione delle regioni nello spazio, egli aveva argomentato contro la tesi leibniziana che considerava lo spazio come determinato dall’ordine delle parti coesistenti di un corpo. In quello scritto aveva sostenuto che se tale concezione corrispondesse alla realtà, allora la mano destra e la mano sinistra, nelle quali i rapporti spaziali fra le parti sono identici, dovrebbero essere congruenti, cioè poter occupare la medesima porzione di spazio, giacché tale porzione di spazio dovrebbe essere determinata esclusivamente da un certo ordine di parti corporee, che abbiamo supposto uguale in entrambe le mani. Ora, come risulta evidente, ciò non avviene: l’identità dell’ordine interno rende le due mani perfettamente simmetriche, ma non congruenti. Kant ne concludeva che lo spazio non può essere considerato un concetto derivato dall’esistenza dei corpi; va bensì concepito come qualcosa di concettualmente anteriore rispetto a essi e che, anziché dipendere dal loro ordine, fonda la possibilità di questo ordine e della loro stessa esistenza. Questo riconoscimento dello spazio come assoluto rispetto agli oggetti si estende nella Critica della ragion pura anche al tempo, perfettamente in linea con le idee sostenute da Newton: l’esigenza comune tanto al filosofo tedesco quanto allo scienziato inglese era infatti quella di fornire punti di riferimento stabili per la costruzione del sapere umano in generale e di quello scientifico in particolare. Nella Critica, poi, l’argomentazione antileibniziana viene rinforzata da considerazioni che traevano origine dal pensiero di Hume, le cui riflessioni sulla conoscenza umana, come Kant stesso riconosceva, lo avevano «svegliato dal sonno dogmatico della ragione», cioè dall’accettazione acritica di alcuni concetti fondamentali della metafisica e della gnoseologia. Hume, in particolare, aveva sostenuto che l’esperienza sensibile non è mai in grado di fornirci conoscenze assolutamente stabili e rigorose, dal momento che, per così dire, può senz’altro dirci come stanno le cose, ma mai come queste devono necessariamente stare. Ad esempio, lo sfregamento ripetuto per dieci volte di un fiammifero seguito per dieci volte dall’accendersi di una fiamma mi potrà dire soltanto che, appunto, per dieci volte lo sfregamento di un fiammifero è stato seguito dalla sua accensione; ma nulla sarà in grado di dirmi sul carattere necessario e universale di tale sequenza; a rigore, quindi, posso sempre aspettarmi che, l’undicesima volta, allo sfregamento del fiammifero non seguirà l’accensione della fiamma. Kant, d’accordo con Hume nel negare carattere necessario all’esperienza sensibile in quanto tale, usa le sue argomentazioni contro la concezione leibniziana del tempo e dello spazio. Se infatti facciamo dipendere questi ultimi da un processo di astrazione derivato dalla conoscenza sensibile dei corpi di cui spazio e tempo sarebbero soltanto delle relazioni reciproche, allora questi perderanno totalmente quel carattere assoluto che solo permette di costruire in essi, come vuole Kant, le matematiche e con esse la moderna scienza matematizzata in altre parole, le posizioni leibniziane vanno respinte perché metterebbero seriamente in forse la stabilità della conoscenza scientifica. Tuttavia, Kant, pur difendendo l’assolutezza di spazio e tempo rispetto agli oggetti contro la loro relativizzazione operata da Leibniz, con ritiene di poterla giustificare al modo di Newton: questi, come si è visto, aveva fondato l’assolutezza di spazio e tempo considerandoli una sorta di attributi della sostanza divina; la soluzione kantiana, invece, è ben lontana da una simile fondazione di ordine metafisico-teologico. Anche in questo caso egli ricorre all’aiuto delle riflessioni di Hume. Questi aveva negato che le sue tesi avessero un esito scettico: ciò che voleva dimostrare, infatti, non era tanto la mancanza di certezza della nostra conoscenza, quanto piuttosto il fatto che tale certezza avesse una base non razionale, bensì psicologica.
In altre parole, non potremo mai dimostrare che al prossimo sfregamento del fiammifero seguirà necessariamente l’accendersi di una fiamma; semplicemente, dopo aver constatato per un certo numero di volte la successione di tali fenomeni, l’abitudine così contratta ci darà una sufficiente certezza circa il suo ripetersi in futuro. La posizione di Kant nei confronti delle tesi humeane può essere così riassunta: egli accetta l’idea secondo cui il semplice dato sensibile non sarà mai in grado di garantire razionalmente il carattere universale e necessario della conoscenza; tuttavia, a differenza di Hume, ritiene del tutto insufficiente una fondazione puramente psicologica della certezza del sapere. È quest’ultima considerazione che porta Kant a quella che egli stesso definì “rivoluzione copernicana”. Riconosciuta l’esigenza di attribuire valore necessario e universale alla conoscenza, bisognerà ammettere, con Hume, che tale carattere non potrà mai derivarle dai dati sensibili, ma dovrà essere individuato nella presenza in ogni soggetto di facoltà conoscitive che, in quanto sostanzialmente identiche in ognuno, garantiranno, pur in presenza di dati sensibili differenti da soggetto a soggetto, che la conoscenza abbia, appunto, carattere di universalità e necessità, ovvero, per dirla con lo stesso Kant, risulti oggettiva. La soluzione del problema gnoseologico starà dunque tutta nel mutare radicalmente punto di vista, facendo ruotare l’intero processo conoscitivo non più intorno all’oggetto, bensì intorno al soggetto. Non si fratta della semplice riproposizione dell’antico innatismo di Platone o dello stesso Leibniz, perché, nella soluzione kantiana, ciò che risulta, per così dire, innato non saranno più i contenuti, bensì la forma della conoscenza, cioè una serie di strutture comuni tali da costituire una conoscenza valida per tutti i soggetti che di quelle strutture partecipano. Fra queste strutture della conoscenza, specificamente nel ruolo di forme della sensibilità, troviamo il tempo e lo spazio Essi, quindi, saranno assoluti rispetto agli oggetti contenuti, nel senso che solo nel tempo e nello spazio il soggetto può percepire degli oggetti, così che tempo e spazio risultano concettualmente anteriori agli oggetti e ne fondano la stessa possibilità di esistenza. Tuttavia, nel pensiero kantiano, questa assolutezza del tempo e dello spazio rispetto agli oggetti è guadagnata al prezzo della loro trasformazione in qualcosa che non appartiene agli oggetti in quanto tali, ma soltanto agli oggetti per come sono percepiti da noi. In altri termini, se tempo e spazio possono assumere un valore universale e necessario solo a patto di essere considerati come forme della conoscenza identiche in tutti i soggetti, allora essi saranno sì anteriori rispetto agli oggetti ed indipendenti da essi, purché sia chiaro che, in questo caso, ci si riferisce non già agli oggetti in sé, bensì agli oggetti fenomenici, cioè, appunto, agli oggetti come appaiono a noi. Riassumendo la posizione assunta da Kant rispetto ai predecessori, si potrebbe affermare che egli ha utilizzato, per combattere le tesi leibniziane, tanto Newton quanto Hume, salvo poi usare le riflessioni di quest’ultimo per assegnare un nuovo significato all’assolutezza dello spazio e del tempo ipotizzata dallo scienziato inglese. Si noti, comunque, che tanto Newton quanto Leibniz e Kant, pur nella radicale differenza delle rispettive dottrine relative allo spazio e al tempo, mantengono ferma l’idea di una strettissima analogia fra queste due dimensioni. Per Newton entrambi si presentano come una sorta di attributi della sostanza divina; per Leibniz entrambi si riducono all’ordine e alla relazione fra le sostanze; per Kant, infine, entrambi sono forme della sensibilità. Perfino quest’ultimo, che pure riconosce loro ruoli chiaramente distinti, come forme del senso esterno e del senso interno, è comunque convinto di una loro sostanziale affinità, tanto da considerare del tutto legittima la rappresentazione grafica del tempo mediante una retta costruita nello spazio. Sarà proprio la legittimità di questa rappresentazione a venire contestata un secolo più tardi da Bergson che, al contrario, sottolineerà la radicale eterogeneità dello spazio e del tempo, purché quest’ultimo venga concepito nella sua autentica natura.
[18] Nella Logica trascendentale della Critica della ragion pura Kant tratterà delle forme dell’intelletto: egli le individuerà nelle categorie, cioè in quei concetti, come ad esempio quelli di causalità e di sostanza, che ci permettono di organizzare il materiale sensibile in maniera da costituire una vera e propria conoscenza. Nell’Estetica trascendentale, da cui sono tratte queste pagine, si studiano le forme della sensibilità, cioè i filtri, per così dire, attraverso i quali il materiale sensibile ci è dato. Esse sono lo spazio e il tempo, intesi, rispettivamente, come forma del senso esterno e del senso interno. L’esposizione metafisica del tempo ne descrive i caratteri fondamentali, mentre quella trascendentale, che seguirà, illustrerà come da esso possano derivare ulteriori concetti.
[19] Apodittico (dal greco apodèiknymi = dimostrare, apodeiktikòs = suscettibile di dimostrazione) è un termine della logica aristotelica usato per definire proposizioni che sono dimostrabili, necessariamente vere o auto-evidenti, o viceversa che sono impossibili. Per Aristotele il termine significava “dimostrativo”, con riferimento a una proposizione o alla scienza stessa, da lui definita “ambito dimostrativo”.
Le proposizioni apodittiche si differenziano da quelle assertive, che si limitano ad affermare che qualcosa è vero o falso, e da quelle problematiche, che affermano solo la possibilità che qualcosa sia vero. Le affermazioni apodittiche sono chiaramente dimostrabili e logicamente certe. Per esempio, “due più due fa quattro” è apodittica, “Roma è più grande di Milano” è assertiva, “una dieta vegetariana potrebbe essere più salutare” è problematica. Nella logica aristotelica “apodittico” si contrappone a “dialettico” come la prova scientifica si contrappone al ragionamento sulle possibilità.
Nella Critica della ragion pura Kant ha messo a confronto le proposizioni apodittiche con quelle assertive e problematiche, intendendo il termine nel senso di “necessario”: un giudizio è apodittico quando afferma o nega in modo necessario, in quanto è “determinato attraverso le leggi dello stesso intelletto”. Secondo questa prospettiva un enunciato è apodittico se è “assolutamente dimostrabile” (ossia tale che una o più successioni finite e consequenziali di formule logiche termina con l’enunciato stesso o con la sua negazione).
La parola “assolutamente” sottolinea che l’esistenza di questa dimostrazione prescinde dalla disponibilità di risorse idonee a determinarla: in altre parole, dire che un enunciato è apodittico non esprime nessun giudizio sulla probabilità che esso o la sua negazione siano dimostrati nel corso della storia umana. Prescindendo della dimostrazione nella storia si gioca il senso di “apodittico” come “dimostrativo” o come “dimostrabile”. Kant stesso aveva distinto, tra le proposizioni apodittiche, quelle dimostrabili da quelle immediatamente certe, recuperando in una certa misura il significato aristotelico della parola.
Gli enunciati “decidibili” (o meno), venuti in auge soprattutto con i Teoremi di Gödel e le Macchine di Turing, sono in particolare gli enunciati apodittici di natura formale, ossia senza componenti fenomeniche. Nell’uso comune il termine è usato come sinonimo di categorico, dogmatico. È frequente anche l’uso del termine “apodittico” come sinonimo di “auto-evidente”: si tratta di un’accezione erronea che fa riferimento alle premesse “anapodittiche” o “immediate” auto-evidenti (e quindi non dimostrabili) del sillogismo.
[20] Il tempo non è un concetto derivato dall’esperienza, o, come dice Kant, a posteriori. Infatti, non possiamo rappresentarci una successione o contemporaneità dei fenomeni se non presupponendo già il tempo come la forma entro la quale percepire tali rapporti. Il tempo è dunque a priori, nel senso che viene concettualmente prima di qualsiasi fenomeno e ne è la condizione di possibilità, In effetti, un semplice esperimento mentale ci farà immediatamente capire che, se possiamo rappresentarci un tempo come svuotato di qualsiasi fenomeno, non sarà assolutamente possibile immaginarci un fenomeno che non sia collocato nel tempo. Questo carattere a priori del tempo, cioè il fatto che esso non derivi dall’esperienza bensì ne sia la condizione necessaria, consente di fare alcune affermazioni altrettanto necessarie, che risulterebbero invece impossibili se il tempo fosse un concetto empirico: l’esperienza, infatti, non è mai in grado di fornirci una conoscenza certa e universale. Del tempo siamo così in grado di affermare in particolare, come sua caratteristica necessaria, che le sue diverse parti sono sempre successive e non sussistono mai insieme.
[21] Il tempo, poi, non è propriamente un concetto universale. Un concetto universale, infatti, si caratterizza per il fatto di avere “sotto di sé” una molteplicità di rappresentazioni individuali, che di esso rappresentano una singola esemplificazione. Il concetto generale di uomo, ad esempio, raggruppa in un certo senso tutti i singoli uomini; questi, a loro volta, sono ciascuno un caso particolare di quell’universale. Non così avviene per il tempo. In questo caso, infatti, tempi diversi sono sì contenuti nell’unico tempo, ma non come singoli esempi del tempo, bensì come parti di esso ciò che può avvenire solamente con la suddivisione di una realtà singola. Kant può così affermare che il tempo è una intuizione a priori: a priori perché non deriva dall’esperienza ma ne è a fondamento; intuizione, perché egli definisce in questo modo la percezione diretta di una singola realtà, distinguendola dal concetto che è sempre una percezione mediata che unifica diverse altre percezioni. Si capisce, così, il motivo per cui il tempo, come già lo spazio, sia stato concepito come forma a priori della sensibilità e non dell’intelletto. Pur non derivando dalla sensibilità, infatti, ha chiaramente a che fare con essa, dal momento che l’intuizione è, propriamente, la modalità conoscitiva della sensibilità che fornisce le singole percezioni, laddove il concetto è la modalità propria dell’intelletto che tale molteplicità di percezioni sensibili unifica. D’altra parte, che il tempo non sia un concetto universale lo dimostra il fatto che la proposizione secondo la quale esso si scandisce in singoli tempi che non possono mai presentarsi insieme è sintetica, cioè, nella terminologia kantiana, tale, per cui il predicato (in questo caso l’impossibilità della compresenza delle parti di tempo) non può derivare da una semplice analisi della rappresentazione del soggetto grammaticale (il tempo). Non si tratta, quindi, di una proposizione in cui il predicato si limita a esplicitare ciò che sarebbe già presente, in modo implicito, nel presunto concetto universale di tempo: essa, anzi, è immediatamente contenuta nell’intuizione di quella rappresentazione individuale che è il tempo. Tale intuizione, poi, ci si presenta come infinita: i singoli tempi saranno soltanto limitazioni di questa rappresentazione intuitiva infinita. Ancora una volta, il tempo non può essere un concetto. I concetti, infatti, vengono costruiti a partire da rappresentazioni individuali: costruisco, ad esempio, il concetto di uomo a partire da una molteplicità di rappresentazioni di singoli uomini. Al contrario, posso concepire i singoli tempi solo a partire dall’intuizione dell’unico tempo infinito della cui divisione e limitazione essi sono il risultato.
[22] L’esposizione trascendentale si riduce a poco, perché, in parte, è stata anticipata in quella metafisica, dove si sono già individuati alcuni principi che si fondano sull’intuizione del tempo. Qui si chiarisce soltanto che il concetto di cambiamento ha la rappresentazione del tempo come condizione di possibilità Infatti, da nessun concetto si potrà mai derivare l’esistenza di caratteristiche contraddittorie nel medesimo soggetto, pena l’abolizione del fondamentale principio logico di non contraddizione. Solo l’ammissione del tempo come forma della sensibilità in cui si svolgono i fenomeni permetterà dì superare la contraddizione, rendendo possibile che predicati contraddittori appartengano al medesimo soggetto purché in tempi successivi.
[23] Il tempo non esiste oggettivamente, cioè indipendentemente dai modi della percezione di un soggetto. E non esiste oggettivante né come realtà assoluta in cui gli oggetti sarebbero immersi né come determinazione relativa dipendente dall’ordine sussistente fra di essi. Nel primo caso; infatti, si cadrebbe nell’assurdo di una realtà che, tuttavia, non è un oggetto o una sostanza; nel secondo, non potrebbe essere concepito, come invece avviene, anche indipendentemente e concettualmente prima degli oggetti che vi sono contenuti. Il tempo è dunque la forma del senso interno, in quanto è la particolare modalità attraverso la quale percepiamo i fenomeni della nostra interiorità. Esso, propriamente, non riguarda i fenomeni esterni, la cui forma a priori è lo spazio. Tuttavia, può essere rappresentato analogicamente nello spazio come una retta; anzi, questa stessa rappresentabilità spaziale del tempo conferma la stretta affinità fra le due dimensioni. Si può poi precisare che, per quanto in senso stretto il tempo sia la forma del senso interno e lo spazio quella del senso esterno, tuttavia, poiché tutte le rappresentazioni, comprese quelle della realtà esterna, in quanto tali riguardano la nostra interiorità, il tempo è, direttamente, forma del senso interno e, indirettamente, forma del senso esterno. In altre parole, mentre i fenomeni interni allo spirito umano si verificano esclusivamente nel tempo, quelli del mondo fisico esterno si collocano sia nello spazio sia nel tempo.
[24] Kant chiarisce che al tempo si deve attribuire realtà empirica, ma anche idealità trascendentale. Con queste espressioni egli vuole sottolineare che esso non esiste se prescindiamo dal nostro modo di percepire sensibilmente gli oggetti tanto interni quanto esterni; o, in altre parole, se ci riferiamo alle cose come sono in se stesse e non alle cose come ci appaiono, cioè ai fenomeni. Il tempo, dunque, ha una validità oggettiva in quanto è la condizione universale e necessaria di tutti gli oggetti che ci sono dati nella sensibilità: in questo senso si può dire che è empiricamente reale. Tuttavia esso è trascendentalmente ideale, cioè non reale, nel senso che, se ci riferiamo alle cose in sé che trascendono la nostra conoscenza empirica e non potranno mai esserci date attraverso la sensibilità, il tempo non ha più alcuna forma di esistenza. Tale idealità, peraltro, non va confusa con l’arbitrarietà delle percezioni soggettive, quali sono, ad esempio, le sensazioni di colore o di gusto, che possono variare da individuo a individuo. La realtà empirica del tempo indica, infatti, che esso è la condizione necessaria e universale – e in questo senso oggettiva - di qualsiasi fenomeno come tale: essa garantisce, pertanto, il rigore della conoscenza empirica, fermo restando che questa non è in grado di attingere le cose in sé che si collocano al di là di qualsiasi esperienza possibile. Si noti che qui, come anche in altri casi, Kant fa un uso un po’ approssimativo dell’espressione trascendentale: questo termine, infatti, secondo le stesse definizioni kantiane, dovrebbe indicare, per un verso, un’indagine che verte non sugli oggetti ma sul nostro modo di conoscerli e, in un senso più specifico, le stesse forme della conoscenza in quanto, pur non derivando dall’esperienza sensibile, soltanto a essa si possono applicare, senza pretendere di farne un uso che vada al di là dell’esperienza stessa. Qui, invece, sembra che Kant utilizzi l’espressione in un’accezione abbastanza vicina a trascendente, nel senso che, se riferito al mondo delle cose in sé che, appunto, trascende l’esperienza sensibile, il tempo, come forma del senso interno, risulta ideale, cioè privo di qualsiasi realtà.
[25] Spazio e tempo, come forme della sensibilità, rendono possibile la formulazione di proposizioni sintetiche a priori. Si tratta di quelle proposizioni che sono sintetiche in quanto non si limitano ad analizzare il soggetto per esplicitarne il contenuto, ma aggiungono effettivamente qualcosa di nuovo a quanto è insito nel concetto del soggetto; sono, tuttavia, a priori in quanto non derivano dall’esperienza, che può sempre essere smentita da un’ulteriore esperienza, bensì dalle forme stesse della conoscenza, e, come tali, hanno un carattere necessario. Il carattere sintetico a priori delle proposizioni derivate dalle forme della conoscenza sensibile dipende da due fattori. Da una parte, si tratta di intuizioni e non di concetti: mentre da concetti universali, attraverso la loro analisi, si possono dedurre verità già in essi implicite, le proposizioni formulate sulla base dello spazio e del tempo sono, per così dire, immediatamente presenti in tali rappresentazioni intuitive individuali. D’altra parte, si tratta di proposizioni a priori, e quindi universali e necessarie, poiché sono costruite non sull’esperienza sensibile, bensì sulle forme conoscitive che di tale esperienza sono condizione. Le proposizioni sintetiche a priori costruite nello spazio e nel tempo sono, in primo luogo, quelle della matematica. Secondo Kant, in particolare l’aritmetica si fonda sulla costruzione del numero attraverso la successiva aggiunta di unità. Tale operazione avviene nel tempo; nello spazio, invece, ma, come si è notato, indirettamente anche nel tempo, avviene ed è resa possibile la costruzione delle figure e delle proposizioni della geometria.
[26] Kant, come si è visto, critica tanto le posizioni di chi, come Newton, considera lo spazio e il tempo come realtà assolute, quanto quelle di chi, come Leibniz, le considera soltanto come un ordine sussistente fra gli oggetti. Qui egli ripete sostanzialmente le obiezioni più sopra avanzate contro tali posizioni Tuttavia, in questo passo, la posizione di Leibniz gli pare decisamente più pericolosa. Infatti, la concezione newtoniana ammette, un po’ contraddittoriamente, l’esistenza di non cose come lo spazio e il tempo, che poi, come contenitori, dovrebbero essere la condizione di esistenza delle cose reali; ma ha comunque il merito di fornire dei quadri di riferimento assoluti entro cui costruire la conoscenza umana del mondo. Viceversa, la posizione leibniziana ipotizza che spazio e tempo siano concetti derivati rispetto all’esistenza degli oggetti di cui essi rappresentano le reciproche relazioni. Di conseguenza, invece di considerare lo spazio e il tempo come condizioni dell’esperienza, Leibniz li fa dipendere dalla stessa esperienza degli oggetti. Ma l’esperienza non può mai fornire conoscenze necessarie e universali, quindi neppure allo spazio e al tempo potranno competere le prerogative dell’universalità e della necessità. Con ciò, anche il carattere rigoroso delle matematiche, che su tali rappresentazioni sono costruite, viene meno. E viene meno anche la possibilità di una fisica matematizzata. Kant, infatti, ritiene che l’uso della matematica in fisica, che all’epoca in cui scriveva aveva già almeno due secoli di successi alle spalle, sia ampiamente giustificabile in base alle sue concezioni. Schematicamente, si potrebbe così sintetizzare la sua argomentazione: se i fenomeni fisici avvengono nello spazio e, indirettamente, nel tempo, risulta immediatamente legittimata l’applicazione a essi delle matematiche che nello spazio e nel tempo si costruiscono. Poco importa, poi, se questi vengano considerati come realtà assolute (anche se tale posizione, come si è visto, è da respingere per altri motivi), o se siano soltanto le forme a priori, uguali in tutti i soggetti, attraverso le quali percepiamo gli oggetti; poco importa, anche, se questi ultimi siano le cose in sé (ipotesi che, peraltro, Kant respinge), o siano soltanto le cose come appaiono a noi, cioè fenomeni. L’importante è che il tempo e lo spazio, e con essi gli eventi fisici che vi accadono, abbiano un carattere universale e necessario, quello che, spesso, nella Critica della ragion pura viene indicato come il loro carattere oggettivo. Ciò che conta, in altri termini, è respingere l’interpretazione leibziana dello spazio e del tempo come concetti derivati e relativi, che renderebbe impossibili tanto la matematica quanto la fisica come scienze rigorose.